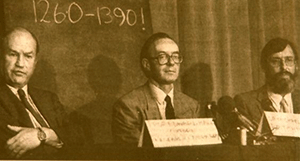 Sindone:
la rivincita del carbonio 14
Sindone:
la rivincita del carbonio 14
Un esperto russo avrebbe scoperto un metodo non distruttivo per datare
il Sacro Lino
Tra qualche anno si potrebbe finalmente datare con sicurezza la Sindone
di Torino, adoperando - questa è la novità singolare - lo
stesso metodo, ora però assai perfezionato, del radiocarbonio (il
famoso "C14"), che, usato in modo improprio, generò il
grosso equivoco del "falso medievale". Questa è la prospettiva
aperta da uno scienziato russo, Dmitrij Kuznetsov, noto in Occidente fin
dal 1993 per i suoi studi in questa materia e per la polemica da lui sostenuta,
in un simposio scientifico sulla Sindone a Roma, con i tre laboratori
di Tucson, Zurigo e Oxford, che nel 1988 avevano esaminato alcuni frammenti
del lino. Kuznetsov è attualmente direttore dell'Istituto di ricerca
sui biopolimeri "E.Sedov" di Mosca e fu a suo tempo un "Premio
Lenin". I biopolimeri sono le catene di molecole prodotte da organismi
viventi: in questo caso la cellulosa. Lo scienziato è tornato sui
suoi studi, fornendone ulteriori elementi, in un articolo scritto per
la rivista Kos. Il metodo del C14, egli precisa, "nel caso dei tessuti
non è accettabile, perché i tessuti hanno caratteristiche
particolari, che ne fanno saltare i criteri. Questo "i luminari che
furono contattati", ovvero i ricercatori di Tucson, Zurigo e Oxford,
"lo sapevano" anche perché uno di loro, Michael Tite
(di Oxford), dirige una rivista specializzata in questa materia: Radio
Carbon. Nel 1988, insomma, era noto a tutti gli addetti che "l'esame
col C14 era ancora troppo immaturo". In breve, vanno considerate
sia la natura della cellulosa, che assorbe dall'atmosfera molto più
C14 radioattivo della media degli altri organismi viventi, sia l'azione
di certi batteri, che la arricchiscono di un ulteriore quantitativo di
radiocarbonio e lo fissano alle sue molecole modificandone così
in modo permanente la struttura chimica. Poiché è sulla
base del decadimento nel tempo della radioattività del C14 che
si misura l'età di un reperto, accade che il decadimento del C14
assorbito dalla cellulosa e fissatosi in essa è inferiore a quello
di altri organismi. Questo è il motivo per cui, avendo perso meno
C14 degli altri materiali, all'esame radiocarbonico il lino appare molto
più "giovane".  Kuznetsov
scrive di aver anche fatto riprodurre sperimentalmente e sulla base delle
documentazioni storiche, in due laboratori diversi (Francia e Russia),
il fenomeno della "carbossilazione" (arricchimento di carbonio)
del lino dovuto all'incendio di Chambéry del 1532, in cui la Sindone
fu coinvolta. Il risultato è che, per effetto della "esposizione
all'alta temperatura in presenza di gas di combustione" ricchi di
carbonio, il tessuto mostra un aumento di atomi di carbonio fino al doppio
del normale. Insomma, afferma lo scienziato russo, il solo incendio ha
causato un grande accumulo di C14: infatti il lino, sul quale è
stata compiuta la simulazione, appare "ringiovanito di circa 600
anni". Dunque la somma degli effetti dell'incendio patito dalla Sindone
e di quelli del "frazionamento biologico" (il cambiamento negli
isotopi del carbonio descritto poco fa) "ci dà sufficiente
certezza per poter dire che la Sindone è notevolmente più
antica del Medioevo". Resta la possibilità di un nuovo ipotetico
esame del C14 da fare sulla Sindone con tecniche progredite: "Qualche
mese fa - scrive Kuznetsov - abbiamo brevettato in America un nuovo sistema
di datazione dei tessuti non distruttivo", cioè che non esige
di bruciare il campione da esaminare. "Questa è una grossa
novità e un grosso vantaggio rispetto a tutti i metodi, compreso
il nostro, usati finora (…) Le modifiche che abbiamo introdotto fanno
sì che i fermenti non danneggino il tessuto: non occorre sottolineare
l'importanza della cosa". Dunque si potrebbe di nuovo studiare direttamente
la Sindone senza danneggiarla? Lo scienziato russo è prudente:
"Se me lo chiedessero non accetterei, perché avrei bisogno
di almeno altri 4 anni per mettere a punto il metodo", cioè
per raccogliere un quantitativo di elementi tale da ricavarne delle leggi.
La cosa è difficile perché i tessuti antichi sono rari e
preziosi, ma già un italiano, Mario Moroni, ha fornito a Kuztnesov
un pezzetto di lino proveniente da Israele e datato storicamente a 2000
anni fa. La strada per la correzione di un clamoroso errore scientifico
è aperta.
Kuznetsov
scrive di aver anche fatto riprodurre sperimentalmente e sulla base delle
documentazioni storiche, in due laboratori diversi (Francia e Russia),
il fenomeno della "carbossilazione" (arricchimento di carbonio)
del lino dovuto all'incendio di Chambéry del 1532, in cui la Sindone
fu coinvolta. Il risultato è che, per effetto della "esposizione
all'alta temperatura in presenza di gas di combustione" ricchi di
carbonio, il tessuto mostra un aumento di atomi di carbonio fino al doppio
del normale. Insomma, afferma lo scienziato russo, il solo incendio ha
causato un grande accumulo di C14: infatti il lino, sul quale è
stata compiuta la simulazione, appare "ringiovanito di circa 600
anni". Dunque la somma degli effetti dell'incendio patito dalla Sindone
e di quelli del "frazionamento biologico" (il cambiamento negli
isotopi del carbonio descritto poco fa) "ci dà sufficiente
certezza per poter dire che la Sindone è notevolmente più
antica del Medioevo". Resta la possibilità di un nuovo ipotetico
esame del C14 da fare sulla Sindone con tecniche progredite: "Qualche
mese fa - scrive Kuznetsov - abbiamo brevettato in America un nuovo sistema
di datazione dei tessuti non distruttivo", cioè che non esige
di bruciare il campione da esaminare. "Questa è una grossa
novità e un grosso vantaggio rispetto a tutti i metodi, compreso
il nostro, usati finora (…) Le modifiche che abbiamo introdotto fanno
sì che i fermenti non danneggino il tessuto: non occorre sottolineare
l'importanza della cosa". Dunque si potrebbe di nuovo studiare direttamente
la Sindone senza danneggiarla? Lo scienziato russo è prudente:
"Se me lo chiedessero non accetterei, perché avrei bisogno
di almeno altri 4 anni per mettere a punto il metodo", cioè
per raccogliere un quantitativo di elementi tale da ricavarne delle leggi.
La cosa è difficile perché i tessuti antichi sono rari e
preziosi, ma già un italiano, Mario Moroni, ha fornito a Kuztnesov
un pezzetto di lino proveniente da Israele e datato storicamente a 2000
anni fa. La strada per la correzione di un clamoroso errore scientifico
è aperta.
Pier Giorgio Liverani
Baima Bollone : il medico che ha fattol’autopsia sul corpo di Gesu’
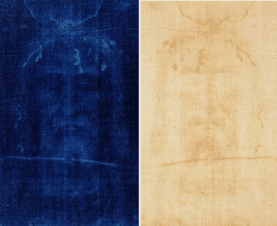 Ha indagato
sulla morte di Moro e di Calabresi e anche sul sangue di S. Gennaro. Ma
soprattutto ha avuto per sei volte tra le mani la Sindone. "E`autentica",
dice.
Ha indagato
sulla morte di Moro e di Calabresi e anche sul sangue di S. Gennaro. Ma
soprattutto ha avuto per sei volte tra le mani la Sindone. "E`autentica",
dice.
N.B..: manca la parte iniziale dell’articolo
In un lenzuolo di lino lungo 437centimetri e largo 111, infine rinchiuso
in un sepolcro.
A Gerusalemme erano circa le 16 del 7 aprile dell’anno 30 o forse
33.
Quasi 40 ore dopo il sepolcro fu trovato vuoto; restava soltanto il lenzuolo.
Trascorsi 1948 anni un medico legale piemontese, Pierluigi Baima Bollone,
ha avuto la possibilità di mettere le mani su quel pezzo di stoffa
giunto nel Duomo di Torino dopo inenarrabili peripezie, e di eseguire
la più complessa e avvincente autopsia della sua carriera, un fatto
unico nella storia della medicina.
Una autopsia senza la salma, perché dicono che il cadavere sia
resuscitato: di più , che sia salito in cielo.
Trascorso un altro quarto di secolo, il professor Baima Bollone, 65 anni,
ordinario di medicina legale nelle facoltà di medicina e di giurisprudenza
dell’Università di Torino, un "archeologo del corpo",
come ama definirsi, che ha indagato anche sulle vittime del terrorismo,
dall’onorevole Moro al commissario Calabresi, è ancora qui
a occuparsi della vita, della morte e dei miracoli di quell’uomo,
l’Uomo della Sindone, lo chiamano Gesù Cristo, il Messia,
il Salvatore, il Maestro, il Figlio di Dio.
Si considera a modo suo risorto anche Baima Bollone, precisamente l’8
agosto 1997, guarda caso un venerdi`.
Forse l’Uomo della Sindone non voleva privarsi del suo anatomopatologo
prediletto.
"Avevo da anni un gnocchetto nel collo, sotto la mandibola destra;
era stato esaminato decine di volte dai colleghi – vai tranquillo
– mi dicevano.
Finchè decido di farmi bello per l’estate e chiedo al chirurgo
di togliermelo.
Dovevo stare sotto i ferri mezz’ora : invece sono uscito dalla sala
operatoria dopo quattro ore.
Gigi, mi dispiace; è un tumore.
Ti restano quaranta giorni di vita se tutto va bene, mi ha informato il
collega.
Quello stesso pomeriggio, nonostante fosse agosto, ho avuto la fortuna
di trovare un amico notaio: e ho sistemato le cose di famiglia, sa dovevo
lasciare moglie e due figlie.
Verso sera è arrivato il miglior anatomopatologo che esista al
mondo, Rosai, lavora a New York ma era in vacanza in Italia, e ha confermato
la diagnosi : carcinoma squamoso del collo.
Pero`a me seccava molto andarmene cosi`in fretta.
Ho fatto la mia bella indagine di mercato ed ho scoperto che uno dei quotatissimi,
per questo tipo di cancro, è il professor Pareshi di Legnano.
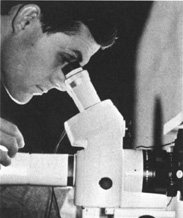 Un orologiaio
: non perde un colpo.
Un orologiaio
: non perde un colpo.
Qualche tempo dopo mi ha fatto la radicale del collo, vede?, mi manca
tutta la parte destra.
Poi la radioterapia, ed eccomi qua, a Dio piacendo.
Mi è servita questa esperienza. Ho imparato ad aumentare la produttività
del 100 per 100 .
Di notte, anziché dormire, scrivo libri, ormai sono una ventina,
cinque sulla Sindone, l’ultimo è "I miracoli di Gesù",
perché ho scoperto che Lui centra, centra sempre;
Ero quasi afono e allora per rivalsa ho raddoppiato le lezioni all’università.
Ho fatto il bravo paziente, mi sono messo in coda alla Asl con tutti gli
altri, un giorno mi è anche capitato un infermiere che, uscendo
dalla porta con il referto in mano, ha urlato: "Chi è quello
con il cancro?"
Si mi è proprio servita"
Nelle mani del professor Baima Bollone i morti si sentono per qualche
ora ancora vivi.
All’ospedale Gradenigo ha preteso che l’obitorio, il suo orgoglio,
fosse vicino alla radiologia e non confinato nell’ultimo sgabuzzino
in base al principio che, tanto, i morti sono morti.
Cosicché gli viene naturale portarmi a vedere il tavolo autoptico
di ultima generazione, le celle frigorifere sormontate da un led rosso
che oscilla tra i tre e i cinque gradi e la "sala dei dolenti",
si chiama cosi`, dove i parenti attendono che i propri cari vengano preparati
per l’ultimo viaggio.
Sulla scrivania tiene il metro con qui prende le misure anatomiche alle
salme, un metro giallo, da sarto, simbolo di una medicina domestica, umana.
Chi è un medico legale ?
" E`una persona che vuole sapere la verità, non si da pace
finchè non ha capito casa è accaduto".
La consuetudine con la morte da assuefazione oppure per lei ogni autopsia
è come se fosse la prima ?
"Dipende dallo stato d’animo. Un bambino morto coinvolge sempre;
pero`capita anche con un vecchietto di ottant’anni : pensi a tuo
padre, a tua madre".
Quando ha potuto toccare per la prima volta la Sindone ?
" Il 6 ottobre 1978. Mi interessavo da tempo di microtracce.
Mi cerco`il Centro internazionale di sindonologia e mi chiese se ero in
grado di provare la natura ematica di alcune tracce sul sacro lino.
Mi fu permesso di prelevare sei coppie di fili, trama più ordito.
La conclusione è stata che è vero sangue umano di gruppo
AB.
Perché non esegui`l’esame del Dna ?
"Anni dopo s’è fatto anche quello.
Ma è risultato inattendibile, perché il reperto è
troppo inquinato.
Vi è un eccesso di cromosomi X femminili.
La Sindone è stata manipolata nel corso dei secoli da tessitrici,
pie donne e religiose".
Che cosa ha provato toccandola ?
"All’inizio niente.
Poi un giorno mi sono seduto dalla parte dei piedi e l’ho guardata
obliquamente; ed è accaduto un fatto straordinario : ho avuto la
nettissima percezione del rilievo, della terza dimensione.
Come se Lui fosse li`, presente.
E`una sensazione che ho riprovato altre volte, anzi tutte le volte.
E anche colleghi scienziati, di religioni diverse dalla mia, protestanti,
ebrei, atei o agnostici, l’hanno provata.
Sembra di vederlo ; è la frase che ci siamo sempre detti".
Come si spiega ?
"Le immagini della Sindone non hanno alcuna direzionalità,
come invece accadrebbe se si trattasse dell’opera di un pittore.
L’assenza di direzionalità è la prova inequivocabile
che esse sono state impresse direttamente da una struttura tridimensionale,
come è appunto quella di un cadavere".
Un intervento pittorico è da escludere assolutamente ?
Assolutissimamente .
Sul lenzuolo ho trovato cellule umane, globuli rossi e cellule epidermiche
in corrispondenza delle lesioni e delle macchie ematiche, materiale che
non puo essere utilizzato da un pittore.
E, quel che più conta, le indagini hanno escluso ogni traccia di
pennellatura o la presenza di particole di colore".
 Due ricercatori
britannici hanno attribuito il lenzuolo a Leonardo da Vinci, che nel 1492
lo avrebbe fabbricato su commissione di papa Innocenzo VIII.
Due ricercatori
britannici hanno attribuito il lenzuolo a Leonardo da Vinci, che nel 1492
lo avrebbe fabbricato su commissione di papa Innocenzo VIII.
"Peccato che la sua esistenza fosse nota 248 anni prima che Leonardo
nascesse".
Quante volte ha lavorato sulla Sindone ?
"Sei"
Complessivamente per quante ore l’ha potuta analizzare ?
"La prima volta per sei giorni consecutivi, giorno e notte.
Per periodi più brevi le volte successive".
Perché hanno scelto proprio lei ?
"Perché ero a tiro. O forse perché davo fiducia".
Dal punto di vista storico, dove e come si materializza la Sindone ?
"La testimonianza più antica è un manoscritto del 1205
conservato nella Biblioteca nazionale di Copenaghen.
In esso Roberto de Clari, crociato della Piccardia, descrive la conquista
di Costantinopoli a cui partecipo` il 12 aprile del 1204 e racconta di
"un monastero chiamato Santa Maria delle Blacherne, dove stava la
Sindone in cui fu avvolto Nostro Signore che ogni venerdi`si alzava tutto
dritto, cosi`che se ne poteva vedere la figura".
Quale è la prova regina della autenticità del lenzuolo ?
"Che non ce n’è una contraria".
Me ne dica un’altra
"Che sono tutte favorevoli".
Sentiamo .
" Cominciamo dal tessuto.
Di lino, a spina di pesce, è un unicum nella storia tessile.
Sul lato lungo presenta una cucitura perfettamente identica a quella di
uno dei circa duemila brandelli di stoffa rinvenuti a Masnada, la città
fortificata da Erode il Grande su una montagna in riva al Mar Morto, dove
nel 72 d.C. un migliaio di Zeloti si suicidarono in massa per non arrendersi
ai romani".
Poi .
"I pollini. Sulla Sindone ve ne sono di 48 tipi.
Uno è il Cistus creticus, una specie di viola che si trova solo
nei dintorni di Gerusalemme.
Una buona metà sono pollini di Gundelia tournefortii, che cresce
tra Gerusalemme e il Mar Morto.
C’è anche un particolare cappero, lo Zygophylum dumosum .
Questi tre vegetali fioriscono in tarda primavera solo in quella ristretta
area della Palestina dove si svolsero i fatti di cui stiamo parlando.
Sugli arti inferiori e sui talloni del Crocifisso sono state rinvenute
tracce di aragonite, un minerale tipico di Gerusalemme".
Poi .
 "Le monete.
Sono due impronte rimaste impresse nella zona delle orbite oculari.
"Le monete.
Sono due impronte rimaste impresse nella zona delle orbite oculari.
Quella sul sopracciglio sinistro l’ho scoperta nel 1996 analizzando
le foto tridimensionali.
Cesare Colombo, un numismatico di Cernusco, mi ha procurato alcuni esemplari
originali.
E` un lepton in bronzo, in ebraico prutah , la più piccola delle
monete battuta sotto Ponzio Pilato per conto dell’imperatore e maneggiate
quotidianamente dai giudei, la monetina della vedova del Vangelo, per
intenderci.
Reca la scritta Tibepiou Kaiacapos, in maiuscolo, che significa di Tiberio
Cesare , e la data LIS, dove L sta per anno, I per dieci e S per sei,
quindi il sedicesimo anno di Tiberio.
Considerando che Tiberio succedette ad Augusto nel 14 d.C., siamo intorno
all’anno 30: la concordanza con la data della crocifissione di Gesù
è totale.
Anche ammesso "e non concesso" che la Sindone sia una bufala,
nessun falsario medievale poteva conoscere queste monetine, identificate
dai numismatici soltanto agli inizi del secolo scorso".
Ma che ci facevano due monetine sopra gli occhi ?
"Nel mondo greco-romano si credeva che il defunto, appena giunto
nell’aldilà, dovesse pagare un obolo al traghettatore sul
fiume infernale Stige.
Ma è difficile immaginare che i discepoli del Maestro abbiano messo
dei simboli pagani su cadavere.
Su questo busillis sono stato pero`illuminato da Giancarlo Altieri, direttore
del Medagliere dei Musei Vaticani, secondo il quale l’ortodossia
giudaica non mostrava particolare avversione per le monete pagane, tant’è
che le offerte al tesoro del tempio venivano fatte in sicli di Tiro con
l’effige del dio Melquart".
Vabbè , ma perché sugli occhi ?
"Il lepton pesava 1,8 grammi, peso sufficiente per tenere chiuse
le palpebre di un defunto, che a circa sei ore dal decesso, per effetto
del rigor mortis, tendono a riaprirsi".
Poi .
"Le ferite. Perfettamente coincidenti con il racconto degli evangelisti.
Al casco di spine sono attribuibili 8 ferite da punta sulla fronte e 13
sulla nuca.
A parte il vivace stimolo doloroso, a ogni respiro o spasmo muscolare
le spine lacerano terminazioni nervose e vasi, provocando un’intermittente
perdita di sangue.
Si contano circa 120 lesioni provocate dal flagello sulla schiena, torace
e faccia.
Una è sul naso.
Tipiche lesioni binate, perché il flagrum romano era costituito
da tre o quattro strisce di cuoio, al termine delle quali vi erano due
palline unite da una barretta.
Dalle colature ematiche sugli avambracci si deduce che i chiodi non furono
piantati nel palmo delle mani: la forza di trazione, pari a un paio di
quintali, avrebbe strappato le estremità degli arti superiori e
il corpo si sarebbe staccato dalla croce".
Furono percio` conficcati nei polsi ?
"Si, in corrispondenza del cosiddetto – spazio di Destot –
che si trova fra la prima e la seconda filiera delle ossa del carpo.
In pratica lo snodo del polso.
Nella Sindone manca il pollice; vi è una spiegazione anatomica:
il passaggio del chiodo lesiona il nervo mediano e cio` comporta la flessione
involontaria del primo dito, che si raccoglie nel palmo della mano".
Veniamo alla ferita nel costato .
"Giovanni scrive che "uno dei soldati con un colpo di lancia
gli colpi`il fianco e subito ne usci` sangue e acqua" .
In gergo medico si chiama sangue dessierato, quindi non vitale, perche
il fenomeno si realizza solo dopo la morte.
L’alone acquoso intorno alla ferita, che è lunga 4,5 centimetri
e larga 1,5, è punteggiato da macchie scure: la prova dell’avvenuta
separazione del sangue nelle sue componenti, cioè globuli rossi
e siero".
Come mori` l’Uomo della Sindone ?
" Non certo per il colpo di lancia .
La crocifissione era studiata apposta per produrre una lentissima asfissia
meccanica.
Il patibolo, a forma di "T", aveva un piolo nel palo verticale
per consentire al condannato di reggersi alla meglio.
Sotto i piedi veniva apposto un appoggio detto suppedaneum .
Tutti accorgimenti per prolungare l’agonia della vittima.
I Vangeli narrano che alla fine Gesù emise un urlo, quindi reclino`il
capo e spiro`.
Descrizione compatibile con un’ischemia cardiaca terminale, assai
probabile in un soggetto lungamente provato dalle torture e deprivato
di liquidi, che si trovava in una situazione nota in medicina come inspissatio
sanguinis, ossia sangue iperviscoso, iperdenso e ormai privo di ossigeno".
Sembrerebbe da escludere un caso di morte apparente .
"L’esame medico-legale attesta senza ombra di dubbio che quel
lenzuolo ha avvolto un cadavere e per non più di quaranta ore,
perché non vi sono tracce di putrefazione.
L’assetto, poi, dimostra chiaramente la rigidità cadaverica.
Inoltre il professor Bruno Barberis, docente di meccanica razionale all’Università
di Torino, ha preso in considerazione le sette più significative
caratteristiche che l’Uomo della Sindone ha in comune con il Cristo
dei Vangeli.
E ha calcolato che se sotto i Romani, per assurdo, fossero stati crocifissi
200 miliardi di condannati, uno solo di questi potrebbe avere tutte e
sette le caratteristiche dell’Uomo della Sindone".
Resta da chiarire come si è formata l’immagine. Qualcuno ha
parlato dello sprigionarsi di un’energia sconosciuta. Potrebbe essere
la Resurrezione quest’energia ?
"Non lo so. In natura le energie conosciute sono soltanto tre: la
radiazione elettromagnetica; la forza gravitazionale; l’energia nucleare.
Qualcuno ha anche ipotizzato una esplosione atomica e in effetti io stesso
ho visto impresse su alcune pareti di Hiroshima e Nagasaki le silhouette
evanescenti di tre persone disintegrate dalla bomba, smaterializzate per
cosi` dire, ed erano molto simili all’Uomo della Sindone.
Ma è una strada che non mi piace e che non porta da nessuna parte.
Senza contare che dopo una esplosione atomica non avremmo più avuto
né Gerusalemme né la Sindone".
E allora ?
" Non conosciamo la natura della forza che ha prodotto l’immagine,
ma il microscopio ci spiega com’è fatta l’immagine.
E con certezza sappiamo che è stata prodotta da una azione fisica,
non soprannaturale .
Del resto, se il buon Dio decide di compiere un miracolo, le pare che
prima debba fissare le regole?".
Pero`nel 1988 la prova del carbonio 14 eseguita in tre diversi laboratori,
Zurigo, Oxford e Tucson, ha datato il lenzuolo fra il 1260 e il 1390 .
"Era la seconda volta al mondo che la radiodatazione al carbonio
14 veniva eseguita su di un tessuto.
Quindi un metodo per nulla collaudato.
E` capitato che il carbonio 14 datasse come vecchi di 20000 anni gusci
di lumache vive.
Ho inviato a Willi Wolfli, direttore del laboratorio dell’Istituto
di fisica delle medie energie presso il Politecnico federale di Zurigo,
alcuni campioni di tessuto prelevati da mummie egiziane; sarebbe stata
una controprova interessante.
Non mi ha neppure risposto".
Ha mai avvolto per quaranta ore in un lenzuolo la salma di una persona
morta in maniera cruenta, per esempio in un incidente stradale, per vedere
cosa resta sul tessuto ?
"In 35 anni passati al vecchio obitorio di via Chiabrera non mi è
mai capitato di vedere impronte di alcun tipo su teli in cui venivano
avvolte le persone indigenti trovate senza vita.
Pero`c’è il caso Les".
Chi è ?
" Un uomo di colore di 44 anni immigrato in Inghilterra dalle Indie
occidentali .
Muore di carcinoma pancreatico nel marzo del 1981 in un ospizio di Thorton.
Gli infermieri notano sulla federa del materasso delle macchie che hanno
resistito anche al lavaggio con la candeggina: è l’immagine
di una mano aperta, completa di polso e dita.
Da un esame più accurato si evidenziano distintamente le impronte
di altre parti anatomiche: mento, braccia, spalle, glutei, cosce.
Il mio collega James Cameron, medico legale della London hospital medical
school, ritiene che siano state prodotte dagli enzimi contenuti nel liquido
che il corpo trasuda nei casi di cancro al pancreas".
Conosce altre sindoni ?
"Le bende funerarie dovrebbero essere recuperate prima dell’inizio
dei fenomeni di decomposizione, il chè ovviamente non rientra nelle
consuetudini di nessun popolo.
Ma nel 1950, durante la ricognizione canonica sulla salma incorrotta del
monaco eremita Youssef Makhlouf, morto la vigilia di Natale del 1898 in
Libano, il sudario mostrava sia pure confusamente i lineamenti del cadavere".
Come è che lei, un laico, è il più entusiasta sostenitore
dell’autenticità della Sindone, mentre le gerarchie ecclesiastiche
appaiono prudenti ?
"Avranno qualche problema a gestire l’argomento.
Io non indosso la talare.
Dico quello che vedi e che penso; è un oggetto autentico".
Per incarico della curia di Napoli ha analizzato anche le reliquie di
San gennaro, che conclusioni ha tratto ?
"Dentro l’ampolla c’è qualcosa che allo spettroscopio
si comporta come il sangue.
Alcuni sostengono che quel liquido raggrumato si puo fabbricare con una
miscela di elementi chimici per poi farlo sciogliere scotendolo.
A parte che più di una volta il prodigio non è avvenuto,
in altri casi è avvenuto senza che l’ampolla venisse toccata
da nessuno, io dico: venite con questo liquido e sottoponiamolo allo spettroscopio.
Si vedrà che non ha nulla in comune con il sangue .
E l’Uomo della Sindone che tipo era ?
"Alto circa un metro e 80, complessione atletica, il cadavere doveva
pesare intorno ai 68 70 Kg .
Barba lunga, capelli fluenti.
Non mi chieda se aveva gli occhi azzurri come il Gesù di Zeffirelli;
non lo so".
Per cui quando nel marzo scorso ha visto sui giornali il volto di Cristo
ricostruito al computer dalla Bbc, un Cristo con le sembianze di un vù
cumprà un po ebete, che cosa ha pensato ?
"Tanto di cappello per la bravura tecnica ; ma è come se andassi
a prendere un cranio nel cimitero di Torino, lo elaborassi al computer
e poi annunciassi: ecco il volto di re Carlo Alberto.
Riderebbe tutta l’italia.
Gli inglesi, fra l’altro, hanno utilizzato un cranio del I secolo
e si sono ispirati per i capelli ad un affresco siriano del III secolo.
Non male come mix".
In definitiva, professore, lei che cosa vede nella Sindone ?
"Come uomo, l’immagine di una sofferenza indicibile.
Come credente, l’immagine vera di Gesù".
Ma come fa, da medico, a spiegarsi la risurrezione di un morto ?
"Non me la spiego.
Infatti è il mistero centrale del Cristianesimo.
Se me la spiegassi non crederei".
Stefano Lorenzetto
Tra i fiori del Calvario: in Israele per scoprire la verità sulla sacra sindone
 Sul lenzuolo
che avvolse il corpo ritenuto di Cristo ci sono tracce di pollini e piante
della Palestina. Uno scienziato che da anni le analizza ha accompagnato
Panorama nel deserto e…
Sul lenzuolo
che avvolse il corpo ritenuto di Cristo ci sono tracce di pollini e piante
della Palestina. Uno scienziato che da anni le analizza ha accompagnato
Panorama nel deserto e…
Nei deserti di Israele alla ricerca di prove sulle origini della Sindone.
A guidarci è un botanico israeliano, Avinoam Danin , dell'università
ebraica di Gerusalemme. In un'appassionante escursione tra i rovi, le
piante i fiori della Palestina, Danin racconta come è nata una
delle ricerche più sere e intriganti attorno al lenzuolo nel quale
potrebbe essere stato avvolto Gesù. Scendendo in un dirupo pieno
di spine alla ricerca di una pianta, la Gundelia turnefortii, Danin ripercorre
la storia degli studi. "Nel 1973 il criminologo svizzero Max Frei
prelevò dalla Sindone dei campioni di pollini. Dall'esame apparvero
165 grani provenienti da diverse piante. Nel 1978 Frei fece un secondo
prelievo e prima della sua morte, nel 1982, dimostrò che almeno
50 diversi tipi di polline provenivano dall'area di Gerusalemme".
I campioni di Frei vennero poi trasferiti negli Usa sotto la cura di Alan
Wangher della Duke University, nel North Carolina. "Wangher e sua
moglie hanno continuato lo studio utilizzando anche foto della Sindone
scattate nel 1931 da Enrie e nel 1978 da Miller" racconta Danin.
"Con immagini polarizzate, ingrandimenti e aumento del contrasto,
le foto hanno portato alla luce la presenza non solo di pollini ma anche
di impronte di fiori e piante che dovevano essere state deposte attorno
al corpo avvolto nel lenzuolo. I Wangher mi chiamarono in causa meno di
due anni fa per individuare le piante provenienti dalla Palestina. Da
allora, con il collega Uri Baruch, abbiamo continuato il lavoro sul terreno".
Mentre parla, Danin sradica un crespo secco e spinoso simile a cardo.
"Ecco la Gundelia. In ebraico lo chiamiamo galgal (ruota) poiché
una volta secca continua a rotolare all'infinito, spostata dal vento,
lungo i deserti. E' nominata più volte nella Bibbia e cresce qui,
nella zona che va da Gerusalemme a Gerico e al Mar Morto. Dei 165 pollini
rinvenuti sulla Sindone, la maggior parte sono di Gundelia. E' stata la
prima pianta a darci indicazione sull'origine del lenzuolo". Sulla
Gundelia Danin anticipa una scoperta affascinante che spiegherà
al congresso sulla Sindone a Torino, il 5 e 6 giugno. "Gli studi
botanici sulla Sindone mettono in risalto attorno alla testa dell'uomo
anche una corona di spine, composta da rami di Gundelia, visibili soprattutto
sopra la spalla destra, e una fascia di steli composta da Ranus palestinum
e da Ziziphus spina christi, dietro la nuca". Sarebbero dunque queste
le piante spinose del martirio sulla fronte dell'uomo crocifisso. Il professor
Danin non ama entrare nel merito delle ipotesi storiche o antropologiche.
A proposito degli esami al carbonio 14 che datarono la Sindone tra il
1260 e il 1390 circa, si irrigidisce e ripete: "Io resto un botanico
e il mio scopo è quello di studiare le prove botaniche dell'origine
geografica della Sindone, né è attraverso la Sindone che
si può ricostruire come venivano seppelliti gli ebrei ai tempi
di Gesù. E' vero però che le prove al carbonio non furono
del tutto attendibili. Probabilmente verranno rifatte dopo il 2000. Ma
la verità scotta sempre a qualcuno". Una verità sulla
quale Danin evita di avanzare ipotesi.
Per lui il caso della Sindone è unico, dal punto di vista botanico:
"Le immagini di piante creano fatti, e i fatti ci portano a delle
conclusioni". Danin rivela un'altra di queste scoperte portandoci
ancora più a sud, nella depressione del Mar Morto. Qui cresce lo
Zygophyllum dumosum, cespuglio alto, verde chiaro. Danin ne mostra un
rametto. "Non lontano dal petto della persona raffigurata nella Sindone
c'è l'immagine di uno stelo come questo. La combinazione della
Gundelia e dello Zygophillum delimitano un'area di origine sempre più
precisa. Quindi lo Zygophillum è importante per risalire alla stagione
in cui fu colto. Quello stelo aveva infatti, come questo, un rametto con
due fogli grasse, e uno senza. Ciò significa che lo stelo sulla
Sindone fu raccolto nel periodo preciso da febbraio ad aprile: il periodo
di Pasqua". Una terza pianta, la Capparis aegyptia, il cugino del
cappero mediterraneo, offre un'ulteriore rivelazione. "Questo fiore,
trovato sulla Sindone come un bocciolo in apertura, ci dice che fu raccolto
e portato a Gerusalemme prima del tramonto, ora in cui si sarebbe riaperto.
Questo ci dà il momento della giornata in cui l'uomo fu avvolto
nel lenzuolo". Danin ha poi scoperto sulla sindone tracce di centinaia
di frutti di pistacchio attorno alle orecchie e alla fronte. "Il
pistacchio non dà frutti in primavera, ma potrebbero averli conservati
e aggiunti come spezie per la sepoltura". E' stato ancora lui ad
aiutare i Wangher nell'individuare altre due immagini che riportano ai
racconti dei Vangeli. "Quando Alan Wangher mi raccontò di
aver trovato traccia della spugna intrisa di aceto, volli vederla. Mi
accorsi allora che accanto all'immagine della spugna c'erano tanti pezzi
di canna". La canna con cui la spugna sarebbe stata porta a Gesù.
Facendo questo studio di Danin è risalito ad un altro elemento.
"Sono venuti alla luce frammenti di corda. E' una corda all'antica,
intrecciata con piante, come quelle che insegno ai soldati israeliani
in casi di emergenza. Doveva essere quella con cui l'uomo fu legato alla
croce, e poiché era intrisa di sangue, chi lo ha deposto sul lenzuolo
deve aver deciso di conservarla lasciandola accanto alla schiena".
Danin parla con semplicità di scoperte che emozionano chi ha fede.
Ma ai grandi interrogativi non risponde. "So solo" conclude
" che se qualcuno avesse deciso di tramandarci un falso di questo
genere, quel qualcuno avrebbe dovuto essere un grandissimo genio".
Simonetta Della Seta
Ed ecco il chiodo della croce
L'eccezionale scoperta sulle ossa di un uomo crocefisso
Non si chiama Yehoshua Mi Nazeret (Jesus Nazarenus) ma Yohanan Ben Hagkol.
Non aveva 33 anni ma 25. Il ritrovamento delle sue ossa resta tuttavia
l'unica testimonianza concreta della stessa crocefissione con cui morì
Gesù. L'ossuario di pietà con lo scheletro di Yohanan (il
cui nome è nell'iscrizione dell'ossuario) è stato ritrovato
in una grotta per sepolture a nord di Gerusalemme, nel quartiere Givat
Ha Mivtar. Quando Vassilios Tzaferis, del dipartimento israeliano delle
Antichità, che dirigeva gli scavi, aprì quell'urna, capì
di essere di fronte a una scoperta storica. Quel morto, certo contemporaneo
di Gesù, non era una personalità e nulla sappiamo di lui,
neppure di quale colpa fu accusato. E' il modo in cui trovò la
morte che l'ha reso celebre: nel suo piede, all'altezza della caviglia,
si vede conficcato un chiodo, con tanto di supporto di legno per tenerlo
più stretto. Un ritrovamento sensazionale. "Sotto l'impero
romano, in tutte le sue province" spiega Tzaferis "migliaia
di persone morirono sulla croce. Secondo le fonti storiche, il supplizio
era per gli schiavi, i prigionieri di guerra e i ribelli al dominio di
Roma. Tra questi ultimi il più noto era Gesù, mandato a
morire nel 30 d.C. circa. Mai tuttavia avevamo trovato prova che la crocefissione
avvenisse con l'uso di chiodi su piedi e mani come descritto dai Vangeli".
Joseph Zias, l'antropologo israeliano che, dopo il ritrovamento, ha studiato
le ossa di Yohanan Ben Hagkol, aggiunge: "E' possibile che la maggior
parte delle crocefissioni avvenisse solo con l'uso della corda che il
condannato, con i piedi appoggiati a un tassello di legno e le mani legate
ai polsi attraverso la croce, morisse comunque di stenti in poche ore.
I chiodi si conficcavano quando il martirio doveva risultare più
doloroso: in casi eccezionali". Gesù di Nazareth fu uno di
questi.1.
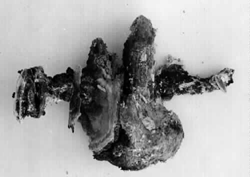
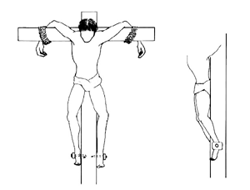
BATTAGLIE CAMPALI
Quadretti di storia del Cristianesimo militante e militare. L'urto arabo
si infrange contro il muro franco. (732: la cultura europea si salva a
Poitiers)
L'inatteso crollo dell'impero visigoto spagnolo a causa di una scorreria
di minore importanza pose l'Islam a contatto con l'unico regno compattamente
cattolico dell'Alto Medioevo. Dopo appena dieci anni dalla battaglia del
Rio Salado, che vide la morte dell'ultimo re visigoto, i berberi si sentirono
abbastanza forti da oltrepassare i Pirenei e conquistare Narbona. Se il
mare non era riuscito a fermare la furia dell'Islam, le montagne non potevano
essere un ostacolo insuperabile. Nel 721 anche Tolosa venne assediata
ma, grazie alle sue fortificazioni riuscì a resistere abbastanza
da permettere al duca Eudo di Aquitania di radunare un esercito di soccorso.
Non sono noti i particolari della battaglia ma si può ragionevolmente
arguire che l'esercito di Eudo fosse composto in buona parte da cavalieri,
abituati a combattere alla maniera visigotica, con possenti cariche frontali
di cavalleria pesante. Gli arabi, guidati da Sham ibn Malik, frustrati
dalla propria inesperienza nella guerra d'assedio, avevano commesso l'errore
più grave per una banda di predoni: rinunciare alla propria mobilità.
Fu così che Eudo poté cogliere di sorpresa gli invasori
e infliggere loro una disfatta senza precedenti. Nella mischia perì
anche il governatore Malik e, sebbene il body count di 350 mila morti
arabi si senz'altro fantasioso è proprio quella cifra che ci può
dare l'idea della completezza della vittoria, la prima riportata da un
principe germanico sui musulmani. Dieci anni dopo una nuova scorreria
araba metteva a sacco Bordeaux e sconfiggeva irreparabilmente la cavalleria
di Eudo. In ottobre gli arabi erano giunti sulle rive della Loira, a Tours,
dove saccheggiarono la chiesa di Sant'Ilario. Qui furono intercettati
da un'armata franca, composta da fanteria austrasiana (ossia germanica)
e cavalleria aquitana e fu chiaro che la spedizione era finita. Del resto
il bottino conquistato era così ingente da rallentare in modo significativo
la marcia degli arabi verso i Pirenei. Carlo Martello, dimostrò
in questa occasione un acume politico e militare a tutta prova. Non si
lanciò all'attacco del nemico ma lo inseguì passo per passo,
continuando a logorarlo, allo scopo di provocarne l'assalto e di metterlo
così in una situazione tattica sfavorevole. Nel contempo non logorò
il proprio esercito, conscio che, alla fine della guerra con gli arabi,
ne avrebbe avuto bisogno per chiudere i conti con il ducato d'Aquitania,
ormai al lumicino. A Poitiers gli arabi decisero di fermarsi e di combattere,
attendendo che i franchi attaccassero a loro volta per primi. Una provocazione
strategica come questa aveva sempre funzionato, giacché ogni regnante
cercava di mettere fine alla presenza e al saccheggio del nemico nelle
proprie province: ma per il cinico Carlo, Poitiers non si trovava in una
sua provincia, bensì nell'Aquitania di Eudo; tanto peggio, tanto
meglio allora! E così per una settimana i due eserciti stettero
a guardarsi negli occhi. I franchi, con i fianchi riparati dai boschi,
i berberi in campo aperto nel loro ricco accampamento, circondati da un
territorio sempre più ostile. Il tempo quindi giocava a favore
di Carlo e Rahman lo comprese perfettamente. I berberi, d'altronde, fremevano
per l'attacco e, provvisti di numerose cavalcature, iniziarono il combattimento
caricando la fanteria franca. Questa accolse l'assalto come un muro di
ghiaccio e gli europei (così vennero chiamati per la prima volta
i combattenti di quelle che oggi sono la Francia e la Germania) dimostrarono
come una fanteria disciplinata e impavida potesse reggere l'urto di qualsiasi
cavalleria. Le lance fermarono l'urto arabo poi fu la mischia nella quale
i giganteschi uomini del nord (ma non erano più giganteschi dei
visigoti e dei bizantini) lottarono con una furia barbarica eguale a quella
dei mori. La francisca (l'ascia da combattimento dei franchi) dovette
farla da padrona, lanciata sui cavalieri armati alla leggera, mentre le
lance trafiggevano i cavalli e i cavalieri venivano trascinati giù
dall'arcione per essere finiti a colpi di scramasax (grosse spade a un
solo taglio e a punta piatta). Le versioni a questo punto divergono. Secondo
alcuni la battaglia continuò anche il giorno successivo, secondo
altri il momento decisivo avvenne proprio alla fine del primo giorno,
quando il duca Eudo dimostrò tutta la sua lealtà di combattere
e uscì alla carica dal bosco dove era stato celato per tutto il
tempo. La difesa statica della fanteria germanica aveva logorato gli assalti
arabi, ma Abd ar Rahman era riuscito a incunearsi nel centro dello schieramento
franco quando alla sinistra dei musulmani la cavalleria aquitana travolse
ogni resistenza e si catapultò verso l'accampamento nemico e verso
quelle ricchezze così gelosamente difese. Fu a questo punto che
ogni resistenza araba venne meno. L'attacco diretto all'elemento più
vitale del dispositivo musulmano ne aveva provocato il crollo immediato,
tanto che solo dopo il tramonto i berberi si accorsero di essersi ritirati
senza il proprio capo, rimasto isolato in mezzo ai guerrieri del nord
e passato da parte a parte dalla lancia di un fante austrasiano. Quando
sorse l'alba i Franchi non trovarono più il nemico, fuggito durante
la notte. Il campo, con il bottino, era rimasto sul posto e Carlo poté
dirsi più che soddisfatto dell'esito di una lotta tutt'altro che
scottata. Re Roderico ci aveva rimesso la vita e il regno in uno scontro
molto minore di Poitiers. Appare dunque arduo smentire quanto afferma
Gibbon: "Una vittoriosa linea di marcia era stata tracciata per mille
miglia dalla roccia di Gibilterra alle rive della Loira: raddoppiate tale
spazio avrebbe portato ai confini della Polonia o alle highlands scozzesi.
D'altronde il Reno non è meno superabile del Nilo o dell'Eufrate
e la flotta Araba avrebbe potuto giungere senza contrasti alle foci del
Tamigi. Forse l'interpretazione del Corano ora sarebbe insegnata nelle
aule di Oxford e i suoi sapienti dimostrerebbero a un popolo di circoncisi
la santità e verità del profeta Maometto".
Alberto Leoni
Una crociata da capire
Studiosi cristiani, ebrei e musulmani a confronto da oggi su un avvenimento
da analizzare con gli strumenti dello storico, senza condanne o assoluzioni
Ricordare la Crociata? Commemorarla? La memoria coincide con la celebrazione?
E la memoria tout court ha qualcosa a che fare con la memoria storica?
E in quali casi il ricordare è un dovere, in quali altri è
preferibile l'oblio? Si ha bisogno dell'etica per fare storia, o il ricorrervi
espone al pericolo della sua degenerazione: il moralismo? Di queste e
altre cose stanno discutendo da qualche giorno i mass media baresi: perché:
perché Bari ospiterà nella cornice del suo Castello Svevo,
da oggi al 13 gennaio, un congresso internazionale in occasione del IX
centenario di quell'evento che nel lessico storico ordinario si definisce
"prima Crociata" e che - com'è noto fin dai banchi di
scuola, per quanto qualcuno può averlo dimenticato - si concluse
il 15 luglio del 1099 con la cruenta presa di Gerusalemme da parte di
alcune migliaia di pellegrini armati provenienti dall'Europa occidentale
(soprattutto della Francia) e con il massacro dei difensori della Città
Santa, arabi e turchi musulmani ma anche ebrei. Un evento da ricordare,
dunque? Parrebbe di sì: ma - obietta qualcuno - come si ricorda
la Shoah o come il Santo Padre ha indicato di recente, per chiedere perdono.
O magari un fatto su cui far cadere un velo di silenzio, come altri propongono.
E non sembra affatto un caso che un esponente politico del centrosinistra
- a Bari e Puglia all'opposizione - abbia stigmatizzato il coinvolgimento
degli enti locali nell'organizzazione del Congresso, denunziandone il
carattere di "sconcertante celebrazione di una cultura della sopraffazione".
Davanti a prese di posizione del genere, confrontate con il programma
del congresso, verrebbe davvero la voglia di citare una frase cara all'attuale
presidente del Consiglio: "Non diciamo sciocchezze". E sarebbe
proprio il caso di citarla: che non può sfuggire a nessuno né
il carattere rigorosamente scientifico dell'evento barese - cui partecipano
alcuni fra i migliori medievisti italiani e israeliani, da Giorgio Fedalto,
a Benjamin Z. Kedar, da Gabriella Airaldi a Sylvia Schein, da Laura Testi
Cristiani e Emanuel Sivan, da Salvatore Fodale a Michele Luzzati, a Stella
Calò Mariani, a Benedetto Vetere, a Cesare Alzati, a Pasquale Corsi
a Michele Piccirillo a molti altri - né il suo taglio decisamente
indirizzato al dialogo anche sotto il profilo civico, dal momento che
fra i relatori vi sono cristiani, ebrei, musulmani e laici, nonché
europei, israeliani e arabopalestinesi. Ma quel che più conta è
che il congresso s'iscrive in un articolato programma d'incontri e di
momenti espositivi e culturali che Regione Puglia e Comune di Bari hanno
promosso, sotto l'egida dello Europe Near East Centre, in preparazione
al Giubileo del 2000: un programma significativamente intitolato "Verso
Gerusalemme", che include anche alcuni viaggi di studio (uno, che
ha ripercorso le tappe della prima Crociata tra Costantinopoli e la Siria,
è già stato compiuto nell'autunno scorso: su Canale 5, "La
Macchiana del Tempo" ne ha messo in onda un "diario" curato
da Simonetta Della Seta il 30 dicembre scorso). Niente memoria celebrativa,
dunque. Per fare storia occorre senso morale, ma quanto si fa ricerca
non si condanna e non si assolve: si cerca di comprendere.
Un congresso sulla Crociata non è per nulla un evento straordinario:
se ne fanno molti, in attesa di quello internazionale, molto importante,
che si terrà appunto a Gerusalemme nel luglio prossimo organizzato
dall'Università Ebraica. Dal momento che la prima Crociata coincise,
nella primavera del 1096, con il primo massacro in massa delle comunità
ebraiche reno - danubiane, è sperabile che a nessuno passi per
la testa che gli studiosi israeliani stiano organizzando "celebrazioni"
dell'evento. La ricerca storica non ha nulla a che fare con la propaganda.
O così, quanto meno, dovrebb'essere. I punti da dibattere e da
chiarire sono due. Anzitutto, la necessità di recuperare il carattere
complesso, dinamico, articolato di quell'evento che - con una parola che
nell'XI secolo non esisteva - noi definiamo "Crociata": un'idea
- forza dell'Europa fra XI e XVIII secolo (non solo nel Medio Evo), che
comunque cambiò più volte aspetto e obiettivi; e che non
impedì affatto (come non impedì il Jihad) che il Mediterraneo
medievale e moderno fosse un'area di scambio e d'incontro fecondissima
a livello sia economico, sia culturale. Questo è, se si vuole,
il paradosso della Crociata: comprensibile, tuttavia, se consideriamo
il movimento crociato strettamente connesso con le vicende strutturali
del tempo (a partire dalle demografiche) e come l'epifenomeno militare
- non esente certo da pagine orribili - d'una serrata, feconda stagione
di scambi all'insegna prevalente dell'amicizia e della reciproca "scoperta
dell'Altro". Da qui il secondo e definitivo punto della questione.
Il centro di tutto un universo politico, religioso, filosofico e spirituale
squadernatosi tra Medio Evo ed Età Moderna fu e resta Gerusalemme.
Le crociate sul piano storico, furono relativamente di frequentare caratterizzate
da altre mete pratiche. Quella concettuale tuttavia, che legittimava le
altre e conferiva loro un senso, restava la Città Santa. A possedere
Gerusalemme mirarono sia i cristiani che i musulmani: gli ebrei, dal canto
loro, la consideravano ovviamente cosa loro. Qui sta il nucleo tragico,
ma anche fecondo di valori, dell'esperienza crociata: una guerra che racchiude
in sé il mistero d'una profonda vocazione all'amore. Non a caso,
la liturgia del voto crociato non aveva nulla di militare: essa consisteva
nella consegna a chi partiva delle pacifiche insegne di pellegrinaggio.
Francesco d'Assisi andò alla Crociata, nel 1219: ma s'incontro
col Sultano, e con lui parlò del Dio comune a entrambi, il Dio
d'Israele. Federico II fu crociato: e col Sultano trattò la tregua,
mentre discuteva forse con lui delle comuni passioni per le stelle e falconi.
E fra Duecento e Settecento - tra il Novellino e Nathan il Saggio di Lessing
- maturava stranamente proprio all'ombra della storia della Crociata,
nel personaggio del Saladino, la figura emblematica di colui che, per
gli occidentali, sarebbe divenuto il simbolo dell'ideale di tolleranza.
Paradosso? Forse. Nella misura in cui la complessità della storia
produce di continuo effetti che, superficialmente considerati, appaiono
paradossi: ma che a un più attento sguardo svelano la loro logica
interna, la loro ragione profonda. Di questo parleremo a Bari. Insieme:
cristiani, ebrei e musulmani, credenti e laici, figli d'un tempo sul quale
si stende l'ombra lunga di crociate e di jihad, ma in cui la riflessione
pacata sul passato comune - sempre comunque legittima di per sé
può concorrere in qualche modo anche a dissipare la bruma del presente
e a preparare un futuro migliore.
Franco Cardini
Tratto da "Avvenire"
Il quadrato magico, un enigma lungo venti secoli
Rino Cammilleri indaga sul graffito di 25 lettere che appassionò
studiosi ed esoteristi. E che fosse nasconde un messaggio cristiano.
Tra i tanti libri gialli in circolazione, ce n'è uno con una caratteristica
particolare: racconta un mistero che non appartiene al mondo della fiction,
ma a quello della realtà. Parliamo del saggio di Rino Cammilleri
ha dedicato al "quadrato magico", un enigmatico grafico di 25
lettere che formano cinque parole sulle quali, da duemila anni, si arrovellano
gli studiosi: rotas, opera, tenet, arepo, sator. Che significa? Secondo
l'"Enciclopedia Britannica", "il seminatore dell'Areopago
detiene le ruote dell'opera". Ma la tradizione, rivelando una frase
banale, non spiega come mai questo "quadrato" sia diffuso in
tutti i continenti, e come mai sia stato considerato, appunto, "magico":
nel Medioevo veniva usato contro le malattie, Paracelso lo utilizzò
come talismano erotico…
Cammilleri ripercorre la storia del "quadrato" pensando che
non si tratti di un semplice gioco di parole ("altrimenti non avrebbe
sfidato i secoli") e alla fine propende per l'ipotesi di un messaggio
cifrato dei primi cristiani, costretti alla clandestinità. Infatti,
se si cerca di anagrammare il "quadrato", si ricava una sola,
possibile scritta con un senso compiuto: due "paternoster" disposti
in croce e affiancati da due "A" e due "O", forse
l'Alfa o l'Omega con cui Cristo si definisce nell'Apocalisse. Ma qui nasce
un problema. Uno di questi "quadrati" fu trovato nel 1936 a
Pompei, durante gli scavi. Ora, siccome Pompei fu sepolta dall'eruzione
del Vesuvio nel 79 d.C., saremmo di fronte alla prova che a quell'epoca
i vangeli (è lì che si parla del "Padre Nostro")
e il libro dell'Apocalisse erano già stati scritti e diffusi, contrariamente
a quanto sostenuto dalla maggior parte degli esegeti. A meno che quel
"paternoster" non sia "uscito per caso": la statistica,
però dice che le probabilità di un "caso" sono
una su diecimila miliardi di miliardi. Ci fermiamo qui: ma su quel "quadrato"
gli enigmi sono talmente tanti che Cammilleri conclude l'indagine sospettando
che quella preghiera così genialmente nascosta sia stata addirittura
"dettata" da Qualcuno. Esagerazioni? Forse. Ma il mistero c'è.
Michele Brambilla
QUEL SUDARIO E`LA SINDONE SPAGNOLA ?
Uno studio sull’autenticità della Reliquia
"I tempi non sono maturi per affermazioni definitive", tuttavia
"il complesso" il complesso di tutti gli elementi fin qui raccolti
" è coerente con le tradizioni dei panni sepolcrali di Gesù"
e dunque il Sudario di Oviedo potrebbe legittimamente porsi come "serio
candidato" alla identificazione con il ‘Sudario’ di cui
parla il Vangelo di Giovanni (20,7) . Dopo la Sindone, che dei panni sepolcrali
del Messia è il più studiato, il più discusso e conosciuto,
tanto che molti ne asseriscono con sicurezza l’autenticità,
oggi potrebbe essere il Sudario ad appassionare sia la ricerca degli studiosi,
che l’opinione pubblica.
Di questo documento, ricco anch’esso di fascino come di storia e
di mistero insieme, il grande pubblico non conosce quasi nulla.
Spesso lo confonde con la Sindone e quasi nessuno sa il significato del
nome: la parola greca "soudarion" sembra ricalcata dal latino
"sudarion" (da sudor), ma potrebbe più probabilmente
venire dall’aramaico " soudora", traducibile forse con
il moderno ‘foulard’.
Non molto di questo lino di Oviedo sanno gli stessi sindologi, per lo
meno fuori dalla Spagna e con le dovute eccezioni. In realtà la
quantità di informazioni antiche e nuove già reperita, che
lo riguardano, è tale da farlo uscire definitivamente dalle nebbie
della semplice devozione tradizionale; e quindi di considerarla una reliquia
consistente e credibile.
Non si puo parlare, è vero , di scoperte clamorose in sé
risolutive, ma il complesso di elementi ricordato un momento fa autorizza
a trasferire il Sudario di Oviedo nella categoria dei documenti storici,
sia pure lasciando prudenzialmente impregiudicata la sua reale appartenenza
agli oggetti della Passione di Cristo.
Questo complesso, cioè la somma e la comparazione dei dati risultanti
dall’esegesi biblica sia vetero che neotestamentaria, dall’analisi
dei testi apocrifi e intertestamentari non canonici, scritti tra la fine
dell’Antico e l’inizio del nuovo Testamento (forniscono molte
informazioni sulla sepoltura ebraica e sui panni che si usavano), dalla
ricerca archeologica, bibliografica e iconografica, infine dall’indagine
scientifica in senso stretto costituisce la vera novità della lunga
ricerca, che Pier Luigi Baima Bollone ha ora riversato nel volume "Sepoltura
del Messia e Sudario di Oviedo"(edizioni Sei, 238 pg. 29000 lire)
appena arrivato in libreria.
Di tutto questo interessantissimo materiale alcune informazioni erano
già note grazie agli studi iniziati una ventina di anni fa da monsignor
Giulio Ricci (morto ne giugno del 1995); altre costituivano le conclusioni
– pubblicate ma non diffuse – delle indagini dei ricercatori
del Ces Centro spagnolo di sinologia: che ha dedicato a questi studi una
sezione di investigazione scientifica (Edices) ; altre ancora, da attribuire
a Baima Bollone, erano apparse su Avvenire per via di indiscrezioni nel
dicembre dell’anno scorso e trovano conferma e qualche precisazione
nel libro. Al termine del quale l’autore si sente in grado di parlare
di ‘autenticità’ del piccolo lino di Oviedo, anche se
parlarne non significa ancora affermarla in modo categorico.
Da scienziato coscienzioso, Baima Bollone non si esprime mai senza avere
le prove documentali. Tuttavia quel ‘complesso di elementi’
di cui si diceva, tra i quali le molte coincidenze e le compatibilità
con i racconti evangelici, con gli antichi usi funerari ebraici, con latrdizione
popolare e con la Sindone di Torino, consente di dare oggi un giudizio
scientifico di grande probabilità che il panno conservato nella
"Camara Santa" della cattedrale del capoluogo delle Asturie
sia quello con cui il volto di Cristo morto fu sommariamente pulito ancor
prima di essere deposto dalla Croce; lo stesso che, anche nella sepoltura
rimase poggiato sopra la Sindone stessa, fino a quando fu ritrovato da
Pietro e da Giovanni .
Molto probabilmente fu la pulizia eseguita con il Sudario – su cui
le impronte sono confuse e quasi illeggibili a un esame superficiale –
che permise alla Sindone di raccogliere, invece, l’impronta tanto
precisa di quel volto. E tuttavia anche tra le macchie vistose del Sudario,
provocate dal materiale organico: ‘ pare di scorgere la fronte, la
piramide nasale e la bocca e che le colate successive del liquido siano
fuoriuscite dagli orifizi naturali del volto ’ allo stesso modo che
appare sulla Sindone .
Il Sudario è un tessuto di lino coevo, ma diverso, come tipo di
tessitura, dalla Sindone (non è a spina di pesce ma ha una trama
e ordito tra loro normali) e certamente è anch’esso di origine
siro-palestinese. Misura cm 85,5 per 52,5 e oltre al siero e al sangue
certamente umano, del gruppo AB, come quello della Sindone ( e come quello
del miracolo di Lanciano – la diagnosi coincide con quella dell’ematologo
Carlo Goldoni di Roma) e al siero conserva residui di polvere e di pollini
( palestinesi e nordafricani, questi ultimi confermano le notizie della
tradizione del viaggio dalla Palestina alla Spagna attraverso il nordafrica),
di unguenti per sepoltura ‘aloe e mirra’ e le tracce microscopiche
di (zolfo, sodio e potassio) della disastrosa esplosione della Camara
Santa causata dalla guerra civile spagnola nel 1934.
Esistono soprattutto numerosi punti di coincidenza con l’immagine
della Sindone, tanto che i sindonologi spagnoli dell’Edices affermano
con sicurezza: " Questo cadavere puo essere lo stesso che lascio`impressa
la sua immagine nella Sindone di Torino; almeno non si riscontra, alcun
dato che si opponga a questo fatto e alla tradizione che unisce questo
tessuto con il volto di Cristo".
Del Sudario è stata fatta, logicamente, anche l’analisi al
radiocarbinio 14. Questa conferma tutti i limiti, i possibili errori e
la scarsa credibilità di questo esame soprattutto se eseguito su
tessuti, se questi sono stati molto manipolati ed esposti.
Su quello del Sudario sono stati trovati, oltre a tracce di un antico
rossetto lasciatovi probabilmente da un bacio devozionale, elementi di
DNA sia maschile che femminile, certamente a causa di manipolazione da
parte di donne.
Ebbene, se la Sindone fu datata fra il 1260 e il 1390, il Sudario dovrebbe
risalire addirittura al 680 – 710 prima di Cristo, entrambi i casi
contraddicendo tutti i risultati delle altre analisi scientifiche.
Un primo elemento documentario: del Sudario si hanno testimonianze scritte
di grande importanza. La più antica risale al 638 ma riferisce
avvenimenti del 570; un’altra, contemporanea, è del vescovo
di Saragozza. I documenti coincidono con la tradizione che fa arrivare
in Spagna la cassa contenente il Sudario e altre reliquie di Cristo verso
il 614 e i Austria dopo l’anno 800.
Insomma, la leggenda diventa storia; conviene fermarsi qui, non senza
precisare che quanto si è riferito non è che una minima
parte di quel "complesso di elementi" con cui Baima Bollone
ha compilato il suo libro, in stile rigoroso e semplice insieme e percio`affascinante
e con sorprendente ricchezza di sapere e vastità di conoscenze
anche in discipline scientifiche: in apparenza lontane dalla sua specialità
accademica di medico legale e criminologo.
Pier Giorgio Liverani