 Medioevo
significa Cristianità
Medioevo
significa Cristianità
Scrive Leone XIII nell’Enciclica Immortale Dei : " Vi fu già
tempo che la filosofia del Vangelo governava gli Stati, quando la forza
e la sovrana influenza dello spirito cristiano era entrata bene addentro
nelle leggi, nelle istituzioni, nei costumi dei popoli, in tutti gli ordini
e ragioni dello Stato, quando la religione di Gesù Cristo posta
saldamente in quell’onorevole grado, che le conveniva, traeva su
fiorente all’ombra del favore dei Principi e della dovuta protezione
dei magistrati; quando procedevano concordi il Sacerdozio e l’Impero
, stretti avventurosamente tra loro per amichevole reciprocanza di servizi.
Ordinata in tal modo la società, recò frutti che più
preziosi non si potrebbe pensare, dei quali dura e durerà la memoria,
affidata ad innumerevoli monumenti storici, che niuno artifizio di nemici
potrà falsare ed oscurare " ( 1.11.1885 )
Dobbiamo ora chiederci però se è mai esistita, come affermano
i Papi, una " civiltà cristiana " una Cristianità
"…
Rispondere a questa domanda significa in primo luogo accertare o meno
la possibilità di ripensare unitariamente circa dieci secoli di
storia ed in secondo luogo stabilire che ciò che li unifica (come
elemento attivo ed unificatore) è proprio il loro essere, il loro
voler essere cristiani.
Si noti che lo stesso termine Medio Evo dalle origini seicentesche e dalla
ascendenze umanistiche, ha un carattere esorcizzante e svuotante; puramente
temporale, esso nega ogni qualificazione e vuole indicare un puro ed insignificante
scorrere di secoli laddove Rinascimento ed Illuminismo sono termini che
presuppongono un positivo giudizio di valore.
Connotazione, dunque, fondamentalmente negativa che designa un’epoca
per ciò che non fu anziché per ciò che essa fu.
Vi allora una secolare eredità linguistica e concettuale da superare;
che è poi evidentemente, lo specchio di una secolare eredità
storica e politica.
Esiste un’unità di fondo del Medioevo, unità temporale
e parziale che ci permette di ricercarne l’essenza; ma entro
questa unità, forse proprio grazie a questa unità, quale
verità; un po’ come accadeva in quei secoli per la lingua:
unita nel suo latino liturgico e sapienziale, la Cristianità era
divisa nella varietà delle lingue volgari.
E allora bisognerebbe parlare a lungo del monachesimo, da quello celtico
(in certa misura ricristianizzante di ritorno l’Europa continentale)
a quello benedettino con le sue varie famiglie, dallo splendore claviacense
all’austerità cistercense.
Bisognerebbe ricordare che la pienezza dei secoli maturi fu preparata
da secoli meno luminosi ma decisivi: come sotto le magnifiche cattedrali
romaniche e gotiche dormono, nelle cripte, santi dal nome oscuro, santi
quasi dimenticati, che gettarono le fondamenta spirituali della Cristianità.
Bisognerebbe ancora ricordare la potente aspirazione all’unità
anche temporale dei Cristiani: quella reductio ad unum, il sogno perseguito
della Sancta Romana Respubblica, il mito – realtà operante
del Sacro Romano Impero.
Bisognerebbe soprattutto tenere sempre davanti agli occhi il continuo
riferimento a Dio, la costante presenza del sovrannaturale, l’assidua
tensione verso il trascendente.
Ciò che dava senso e forma alle realtà terrene.
Caratteristiche della Cristianità
1. Fondamento teologico della Cristianità
La Cristianità trova il proprio fondamento teologico all’interno del dogma della regalità sociale del Cristo (Cristo Re dell’Universo).
2. Cristianità come epoca dell’ et-et
Per esplicitare questo concetto fondamentale per la comprensione dell’epoca
medievale, è necessario prendere spunto da alcune nozioni tipiche
i questi periodo storico.
Una di queste, è la nozione che si è avuta durante il Medioevo
della libertà individuale. Essa non appare come un bene o un diritto
assoluti. La si considera piuttosto come un risultato: colui la cui sicurezza
è garantita, colui che possiede terre sufficienti per tenere testa
agli agenti del fisco e per difendere da sé il proprio dominio;
costui è reputato libero, perché ha in effetti la possibilità
di fare ciò che gli piace. Accanto a questa libertà individuale
esiste però la libertà del gruppo che in molti casi
limita e circoscrive la libertà individuale.
Ci si mostra molto puntigliosi su tutto ciò che concerne i diritti
del gruppo al quale si appartiene, e che sono considerati indispensabili
alla sua esistenza: libertà familiari, corporative, comunali e
altre, sono sempre discusse aspramente e rivendicate; in caso di necessità
le si difende con le armi.
3. Senso pratico ed astrazione, ideologia e senso dell’umorismo
L’uomo del Medioevo si diverte di tutto: nelle sue mani il disegno
si trasforma facilmente in caricatura e l’emozione confina con l’ironia.
E’ un carattere da non perdere di vista quando si studia l’epoca,
poiché più di una volta, prendendo troppo sul serio certi
testi si è giunti soltanto a renderli pesanti e a sfigurarli.
In moltissime occasioni questa capacità di " divertirsi "
appare in situazioni del tutto inattese; quando si scolpiscono sugli stalli
delle chiese dei canonici dai tratti grotteschi, in posizioni ridicole;
quando il tal cronista, parlando degli effetti del fuoco greco esclama,
a proposito di quest’acqua che diffondeva il fuoco: "Essa costa
molto cara, quanto il vino buono".
Questo umorismo medievale è del resto curiosamente legato alla
fede religiosa che anima l’epoca, di cui si deve tener conto anche
nei minimi particolari della storia e della vita corrente. La sua fede
le insegna, in effetti l’originalità della persona divina,
alla quale nulla è impossibile e che, per conseguenza, può
rovesciare le situazioni come le piace.
4. Casa e pellegrinaggio
Ogni esistenza dell’uomo della Cristianità è tenacemente
centrata sul focolare, la famiglia, la parrocchia, il feudo, il gruppo
al quale essa appartiene.
Non c’è una costumanza, non una minima abitudine che non tenda
a rafforzare questo attaccamento e a farlo rispettare. Una città
difende le proprie libertà altrettanto gelosamente quanto un signore
la propria castellania; le associazioni si dimostrano altrettanto intransigenti
nei confronti dei loro privilegi; quanto un pare di famiglia del suo feudo,
per piccolo che sia; il manior, il podere in cui uno dimora, è
considerato un santuario.
E tuttavia questi esseri legati al suolo, legati ai loro antenati e
ai loro discendenti, furono in perpetuo movimento. Il medioevo è
contemporaneamente un’epoca in cui si costruisce, e un’epoca
in cui ci si muove.
Ha assistito ai più grandi spostamenti di folle, alla circolazione
più intensa che la storia del mondo abbia conosciuto, eccettuata
la nostra epoca. Che cosa sono le imprese di colonizzazione, quelle dei
Greci e quelle del secolo scorso, a confronto degli esodi di popolazione
che segnarono le Crociate!
E si tratta di esodi fecondi, senza niente in comune con i lamentosi greggi
che una folla in marcia rappresenta per noi. Due soli secoli sono stati
sufficienti per veder nascere, vivere ed estendersi una civiltà
originale, forgiata pezzo per pezzo, i cui resti ci meravigliano ancora.
La vita degli uomini della Cristianità era fatta di andirivieni:
dal mercante che lascia la sua bottega per le fiere di Champagne o di
Fiandra, o per trafficare sui banchi di vendita l’Africa o d’Asia
Minore, fino all’abate che se ne va ad ispezionare i suoi monasteri;
dagli studenti in cammino da un’Università all’altra,
fino ai signori che visitano il loro contado, o ai vescovi in giro per
le loro diocesi; dai re che partono per la Crociata, fino al popolo minuto
che cammina verso Roma o San Giacomo di Compostella …
Tutti chi più chi meno, partecipano di questa febbre del movimento
che fa del mondo Medievale un mondo in marcia.
Dall’insieme risulta una confidenza nella vita, una gioia di vivere
di cui non si trova l’equivalente in nessuna altra civiltà.
Quella sorta di fatalità che pesa sul mondo antico, quel terrore
del Destino, Dio implacabile al quale gli dei stessi sono sottomessi:
il mondo Medievale l’ha totalmente ignorato.
Nella sua filosofia, nella sua architettura, nel suo modo di vivere, ovunque
brilla una gioia di esistere, una potenza di affermazione, di fronte alla
quale torna la mente la parola scherzosa di Luigi VII: "Noialtri,
alla corte di Francia, non abbiamo che pane, vino, e allegria".
Parole magnifiche, che riassumono il Medioevo, epoca in cui si seppe,
più che in ogni altra, apprezzare le cose semplici, sane e gioiose:
il pane, il vino e l’allegria.
Ammirazione nostalgia ma alterità
E’ necessario, quindi, confermare il valore esemplare che per il
cattolico dovrebbe avere la civiltà medievale senza dimenticare
che l’ammirazione e la nostalgia per questo periodo non può
essere disgiunta da una profonda alterità. Lo studio dell’epoca
medievale o meglio della Cristianità assume per noi una capacità
di stimolo e di riferimento, forma liberatrice del passato nei confronti
del presente che può essere conservata e utilizzata.
La Croce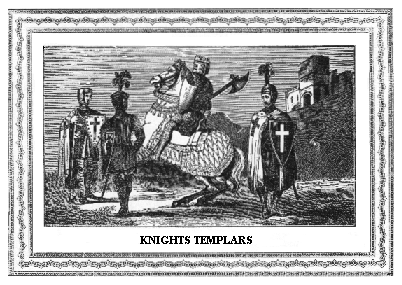
La croce rende esplicito il mistero del centro essa è diffusione,
emanazione, ma anche riunione e sintesi. E’ il più completo
di tutti i simboli; nessun altro quanto questo sa condensare nel più
essenziale dei segni la più vasta delle sintesi. Forse è
il simbolo più universale, infatti tutte le civiltà lo hanno
compreso nel proprio patrimonio simbologico.
E’ un simbolo spaziale e temporale e questa proprietà privilegiata
lo rende adatto ad esprimere il mistero del cosmo animato. Per questo
essa si sovrappone sempre – in un modo o nell’altro, e con una
sovrapposizione non tanto geometrica quanto immaginaria – al tempio
cosmico che è la Chiesa.
La croce del microcosmo–chiesa non è tanto quella costituita
dal suo perimetro (la navata che si incrocia con i bracci del transetto,
dal momento che questa forma può fare difetto) quanto quello della
sua intima espansione nelle quattro direzioni dello spazio. E’ questa
relazione psicologica, così imperativa nell’uomo, che gli
conferisce misteriosamente la coestensione dei quattro orizzonti, dei
quattro venti dello spazio.
E’ ancora essa che iscrive nello spazio il cerchio delle stagioni,
scandito dall’alternanza rituale dei solstizi e degli equinozi che
sono i quattro punti cardinali del ciclo liturgico (Natale, Pasqua, San
Giovanni, San Michele).
E’ ancora essa che salda la croce cardinale terrestre sulla celeste
e fonda il simbolismo dei loro rapporti.
Questo rapporto è animazione, e la sua espressione più vivamente
percepita dalla psiche umana è quella della rotazione della sfera
del mondo attorno al suo asse polare; tale asse è perpendicolare
al grande cerchio dell’orizzonte, del luogo sacro e forma con una
qualsiasi delle parallele al suolo una croce, questa volta drizzata verticalmente.
Queste due croci, croce orizzontale, d’orientamento cardinale, e
croce verticale assiale, in realtà non sono che una sola croce:
quella a tre dimensioni e a sei bracci che orna i campanili delle chiese
orientali. In occidente, essa assume la forma della girandola in cima
ai campanili divisa alla base da una croce orizzontale orientata. Tale
è la croce del mondo vivente, la croce che fa della chiesa il centro
e la ripetizione del cosmo liturgico. Poiché essa è perfettamente
coestensibile ai simboli del cosmo naturale non meno perfettamente misura
il microcosmo che è la chiesa. In essa e per essa la vita e il
movimento emanati dal polo celeste, simbolo di divinità, si trasmettono
al centro sacro terrestre: all’altare, al santuario, alla chiesa,
e irraggiando da questo centro, a tutto l’universo.
La croce tridimensionale è la più perfetta immagine sacra
del mondo. E’ il segno visibile della trinità nell’unità.
Il sei caratterizza la creazione - emanazione; si ricordino l’opera
di sei giorni e tutti i motivi sestuplici che si incontrano nel contesto
della creazione, per esempio sui portali romanici ove si potrà
incontrare sei volte la maschera della Terra che vomita viticci tra cui
giocano alcuni animali.
Il settenario indica la conclusione e la pienezza (il settimo giorno)
ottenuti quando si aggiunge al computo dei sei bracci il punto centrale
da cui essi emanano o dove vengono assorbiti nell’unità indifferenziata.
Dio sta in questo centro: "Volgendo il suo sguardo verso queste sei
estensioni come verso un numero sempre uguale, Egli conclude compiutamente
il mondo; Egli è l’inizio e la fine, in Lui si compiono le
sei fasi del tempo, e da Lui esse ricevono la loro indefinita estensione;
là è il segreto del numero sette" (Clemente d’Alessandria).
La croce tridimensionale può essere rappresentata in modi assai
differenti.
Sulla superficie piana la forma più semplice è la stella
a sei braccia, più o meno regolari, sia per la loro dimensione
che per la loro disposizione; la verticale Zenith Nadir appare spesso
distinta dalla croce orizzontale e orientata da una freccia, una fiamma,
un cerchio un motivo qualsiasi.
Nella croce tridimensionale si riconosce la forma nota del crisma, simbolo
polivalente vecchio come il mondo, che la simbologia cristiana si è
compiaciuta di utilizzare, dopo un semplice battesimo mentale che risultava
sia dalla lettura della X e della P, le prime due lettere del nome di
Cristo in greco, sia dall’incrocio di questa X con la I di Jesus.
Il monogramma di Cristo diventava la formula simbolica della salvezza
universale operata dalla croce di Gesù Cristo.
Quest’ultima non appariva sul labaro di Costantino, mentre compariva
il crisma; la conversione dell’imperatore consentì la sostituzione
con mezzo secolo di ritardo: l’impero divenuto cristiano, abolendo
il supplizio della croce, soppresse l’odiosa sensazione connessa
allo strumento di tortura finché restò in uso.
La croce latina compare in seno al crisma stesso ma conserva in alto l’anello
che ricorda la P e costringe a rilevare nell’incrocio l’antica
X raddrizzata.
All’inizio del V secolo l’anello sparisce, e nasce la nostra
tradizionale croce cristiana. Il crisma viene usato ancora, anzi in quest’epoca
raggiunge le sue espressioni più perfette e trae dalla croce latina
l’alfa e l’omega che spesso e volentieri gli vengono associate
per assicurargli una cristianizzazione da ogni equivoco segnico: questo
riferimento al Cristo dell’Apocalisse, Pantocreatore e maestro del
tempo, conferisce al vecchio simbolo le dimensioni della Rivelazione.
( Spiegazione del mosaico del Battistero di Albenga).
Se la spiritualità cristiana è affascinata dalla croce,
ciò non è dovuto in primo luogo alla sua insondabile ricchezza
simbolica!
E’ che il Cristo morendo inchiodato ad una traversa fissata ad un
palo ne ha fatto il segno storico del compiersi del disegno divino.
Per il credente, la croce primaria è l’ultima che con le sue
braccia aperte esprime un amore grande come il mondo non aveva mai conosciuto.
Un amore che ha trovato nello strumento del sacrificio il simbolo della
sua grandezza.
La passione di Cristo ha trasfigurato il segno della croce; ormai, al
di là dell’antica immagine, è l’universale e misteriosa
bontà del uso Signore che l’uomo redento percepisce e venera.
Attraverso la comunione con il segno sacro, egli penetra nelle vertiginose
profondità del disegno di Dio sul mondo, così come diceva
san Paolo agli Efesini.
San Cirillo spiega ai suoi catecumeni: "Dio ha steso le mani sulla
croce per abbracciare le estremità dell’universo. Anche il
monte Golgota è diventato il perno del mondo". Con Firmico
Materno, il perno diventa l’asse dinamico che unisce celo e terra:
il legno della croce sostiene la volta celeste, e consolida le fondamenta
della Terra. Andrea di Creta, riprendendo san Paolo, fa una litania della
croce: "Riconciliazione del mondo, determinazione delle frontiere
terrestri, altezza del cielo, profondità della Terra, legame che
unisce la creazione, lunghezza di tutte le cose visibili e larghezza dell’universo".
"Il segno della croce apparirà nel cielo il giorno del Giudizio
finale", canta l’inno della festa dell’Esaltazione della
santa Croce nella liturgia latina.
La croce salda il ciclo del tempo del mondo, il grande cerchio creazionale:
essa pone su tutte le cose il sigillo ultimo che le giudicherà
secondo l’amore incarnato: "O croce piantata nella terra che
rechi frutti in cielo! O nome della croce, che racchiudi in te l’universo!
Salute a te, o croce, che tieni legato il cerchio del mondo! Salute, o
croce, che hai saputo dare alla tua sembianza in forme una forma piena
di senso profondo!" (Atti apocrifi di Andrea).
Essa è il polo e il motore immobile di un mondo in movimento; stat
crux dum volvitur orbis, la croce sta fissa mentre il mondo ruota: è
il motto di tutti i monaci.
La croce è il grande segno cosmico; il segno dell’universo,
il segno dell’uomo; il segno di Dio presente e agente in entrambi.
E’ allo stesso modo un segno biblico, un segno storico, un segno
personale: e di nuovo si verifica il contrasto incredibile tra questo
insignificante simbolo con l’incommensurabile e adorabile ricchezza
del mistero della croce di Gesù, figlio di Dio che lo fa essere
fra tutti i simboli il più evocativo.
La croce e l’albero
( Spiegazione del mosaico absidale di San Clemente a Roma )
Ecco ora una di quelle leggende religiose, come del resto ne circolavano
un tempo, che servivano da catechismo al popolo dei credenti con l’incomparabile
privilegio di introdurre attraverso l’ingenua fantasia del racconto
nell’intimo dei misteri.
Si tratta del Viaggio di Set in paradiso, uno dei tesori della Cristianità
medievale.
( Spiegazione dell’icona con la tomba di Adamo e spiegazione del
Crocifisso con gli occhi aperti; albero della Rivoluzione francese e albero
del P.D.S. )
Un ultimo testo, il più bello fra quanti furono scritti per celebrare
i misteri della croce, sintetizza le linee principali del suo simbolismo
nel contesto cristiano.
Quest’inno fu composto da Ippolito da Roma all’inizio del III
secolo. L’iconografia di cui abbiamo parlato non può essere
esattamente apprezzata se non in quella luce che l’ha visto nascere.
Ogni espressione cela una o più illusioni.
A metà del secondo paragrafo si passa dall’albero della Croce
al Cristo che su di essa ha preso posto.
Mozzecane, 29 Gennaio 1999
A.M.D.G.E.M.