"SOLSTIZIO
ETERNO" - parte seconda - 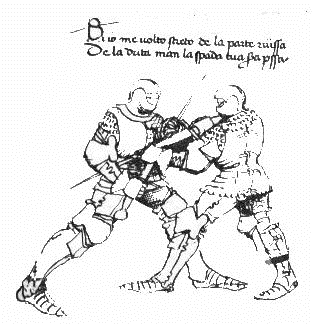
Il portale è costituito da un rettangolo inferiore, i battenti
(ingresso per gli esseri terreni, di questo mondo) e da un semicerchio
sovrastante, sotto l’arcivolto, raffigurante il cielo, il sacro.
Il primo richiama la navata, rettangolare, anch’essa destinata ai
terreni, l’altro, semicircolare, richiama l’abside, la sancta
sanctorum, il mondo del sacro. La simbolica dell’architettura romanica
sta sotto il segno del rapporto tra quadrato e cerchio, tra il manifestato
e il non manifestato, tra il profano e il sacro.
Sul portale superiore è raffigurato, nel romanico del XII secolo,
Cristo in gloria, re e giudice, con le braccia aperte, benedicente. "Io
sono la porta", dice l’immagine. E’ circondato dal tetramorfo,
i quattro viventi, gli Evangelisti, ciascuno raffigurato col suo simbolo:
sono i custodi del tempio della nuova Legge. Infatti, chi varca la soglia
del portale passa dalle vecchia legge, che rimane fuori, nel prenartece,
per entrare nel mondo del nuovo testamento. L’iconografia è
rigorosamente divisa secondo la sua provenienza: fuori, sui battenti e
nel prenartece, soggetti e simboli riguardanti l’Antico Testamento,
dentro il tempio immagini ispirate dal Vangeli; mentre su alcuni portali
monumentali oppure sulla parete ovest all’interno della chiesa sono
presenti scene del giudizio universale di ispirazione giovannea.
Il Cristo del portale romanico è solare, sempre in gloria.
Appena un secolo dopo, nel gotico, è sostituito da un Cristo in
agonia, crocefisso. Profondo mutamento di mentalità teologica:
al "Cristus vincit" del romanico seguirà il "Cristus
Victus".
L’uomo – Dio sconfitto dalla morte prenderà il posto
del Dio – uomo che sconfigge la morte. Il mondo solare si oscurerà.
I difensori del gotico parlano di una "umanizzazione" del Cristo
che soffre e muore come noi, trascurando l’essenza del cristianesimo
che non è fondata sull’agonia di Cristo, ma sulla sua resurrezione.
Mutano anche certi caratteri dell’iconografia. I capitelli e le grondaie
del tetto si riempiono gradualmente, nel gotico, di orrendi mostri. All’inizio
del rinascimento il tribunale ecclesiastico chiamato inquisizione diventerà
istanza di supplizi; l’intransigenza prende il posto del dibattito
teologico. Non sembra paradossale che l’inquisizione arriverà
all’apogeo proprio nel Rinascimento, in nome dell’uomo decretato
"centro dell’universo?" E come si spiega che un certo scrittore,
Umberto Eco, abbia scelto come sfondo del suo scritto ("Il nome della
rosa") proprio questo periodo fosco del medioevo, con la sua decadenza
spirituale, e non il solare XII secolo di armonia meditativa e fertile
ricerca della conoscenza in tutte le direzioni? Certamente non si può
spiegare soltanto col suo poco amore per il vero medioevo, il secolo bernardiano
della fioritura su tutto il continente dell’architettura romanica
e della sua mirabile arte. Bisognerebbe conoscere i suoi segreti legami
con quelle istanze nascoste che hanno operato un così grave mutamento
nell’equilibrio spirituale dell’uomo.
L’importanza simbolica della porta è immensa: tramite essa
si accede alla rivelazione. La sua decorazione riveste un ricco significato.
E’ come una porta – specchio che riflette le armonie del creato
e, nello stesso tempo, introduce ai misteri. Entrando nella chiesa romanica
si entra per la porta maggiore del cuore stesso dell’universo. Bisogna
entrare preparati a saper decifrare, su questo percorso iniziatici che
va dalla porta all’altare, queste "pietre miliari" del
cammino verso Dio che sono i simboli, scolpiti sui capitelli, affrescati
sui muri o sulle colonne, espressi nelle vetrate, sui cibori, nei mosaici
parietali e sui pavimenti. Ma, prima di entrare, prima d’incamminarsi
sull’asse longitudinale che conduce all’altare, dobbiamo fermarci
su un suo particolare significato: l’orientamento.
Il tempio romanico è orientato, l’abside guarda verso l’oriente,
verso la luce del sol levante. Per estensione la parola latina orientatio
si riferisce alle sue coordinate che determinano il rapporto chiesa –
cosmo: l’asse orizzontale est – ovest, e l’asse verticale,
l’axis mundi. Il costruttore può scegliere l’orientatio
dell’asse orizzontale, l’axis mundi invece è implicita
alla condizione mistica dell’edificio. Per sottolineare l’importanza
che si dava nel primo romanico all’orientatio orizzontale, racconterò
un esperienza personale. Finito il restauro del rudere di una pieve cistercense
del Mille, a Gallese, dove abito, mi sono fermato a osservare con attenzione
com’è orientata. Mettendo la bussola sull’asse orizzontale
del pavimento, ho constatato che l’asse no corrispondeva con l’est
magnetico. Essendo una pieve lontana dall’abitato, non era condizionata
dal collocamento urbanistico. Perché allora non è orientata
verso l’est geografico? Al momento pensai che il contadino costruttore
di questa chiesa povera, non conoscendo la bussola, la orientò
ad occhio: dopo un po’ di tempo scoprii con stupore che l’asse
orizzontale è orientata verso il punto dell’orizzonte in cui
sorge il sole nel giorno del primo maggio, festa dei patroni SS. Filino
e Giacomo di questa chiesa. Le misurazioni interne mi hanno confermato
il rigore delle proporzioni squisitamente cistercensi basate sul multiplo
del quadrato e del cubo.
Sto pensando a certe chiese di oggi, chiamate da Hans Sedlmayr "garages
per le anime" costruite dalla nomenclatura laica che conta, che non
sono né orientate, né minimamente sfiorate da intenzioni
simboliche. Veri parcheggi urbani per soggetti solitari anacronistici…
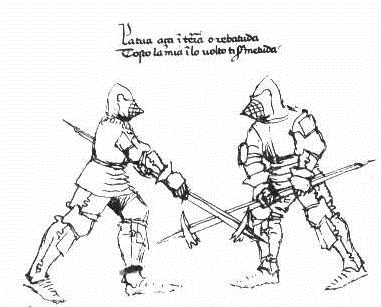 L’orientatio
tradizionale verso il sol levante non è nel romanico una regola
assoluta. In certi casi particolari l’asse orizzontale passa su un
meridiano nord – sud, l’abside si affaccia verso il nord, in
direzione della stella polare. Questo astro che conclude la costellazione
dell’Orsa maggiore è antichissimo punto di riferimento nella
cultura del sacro. Essendo in senso astronomico l’unica stella fissa
dell’emisfero boreale, il perno attorno a cui ruotano tutte le altre
costellazioni è stato considerato il centro mistico del mondo conosciuto.
Faro che indicava il nord ai navigatori, era avvolto dall’aurea del
mito primordiale: piede del trono di Dio, porta del paradiso. Ogni chiesa
romanica, anche se non "orientata" verso nord, era collegata
simbolicamente con la stella polare da un’asse cosmica.
L’orientatio
tradizionale verso il sol levante non è nel romanico una regola
assoluta. In certi casi particolari l’asse orizzontale passa su un
meridiano nord – sud, l’abside si affaccia verso il nord, in
direzione della stella polare. Questo astro che conclude la costellazione
dell’Orsa maggiore è antichissimo punto di riferimento nella
cultura del sacro. Essendo in senso astronomico l’unica stella fissa
dell’emisfero boreale, il perno attorno a cui ruotano tutte le altre
costellazioni è stato considerato il centro mistico del mondo conosciuto.
Faro che indicava il nord ai navigatori, era avvolto dall’aurea del
mito primordiale: piede del trono di Dio, porta del paradiso. Ogni chiesa
romanica, anche se non "orientata" verso nord, era collegata
simbolicamente con la stella polare da un’asse cosmica.
Appena entrati nella navata il piede tocca sul pavimento quel curioso
disegno fatto da tasselli di pietra chiamato il Labirinto, il guardiano
delle verità custodite contro i "Demoni del deserto",
i non eletti, difensore del Centro, a cui stiamo per avvicinarci. Significa
"la via difficile" verso la Verità. Il più grande
ancora conservato si può vedere a Chartres. Molti sono stati distrutti,
eliminati, considerati stupidi giochi per bambini. Col tramonto del medioevo
saggio, nell’oscuramento della ragione mistica, il senso del labirinto
si è perso. In certi casi "benefattori" della chiesa
hanno finanziato la distruzione del labirinto per sgomberare il tempio
dalle tracce dell’"oscurantismo". Da allora la nostra società
occidentale ha preso davvero la via difficile di un labirinto in cui si
è arenata nei meandri della propria ignoranza spirituale.
Varcare la soglia, passare dalla vecchia alla nuova legge, è il
primo tema simbolico che ci introduce nel tempio. Il capitello conservato
a Autun raffigura "Il mulino mistico", nel trapezio di pietra
la composizione è disposta su due registri: sopra un personaggio
(mosè), chinato su un piccolo mulino con la ruota segnata dalla
croce, versa da un sacco il grano. Sotto, l’altro personaggio (san
Paolo) raccoglie la farina. Significato: Mosè mette il grano grezzo
della vecchia legge nel mulino del cristianesimo, mentre San Paolo raccoglie
la farina bianca della legge nuova per espanderla nel mondo. Esemplare
simbolo che riassume il passaggio dal vecchio al nuovo Testamento.